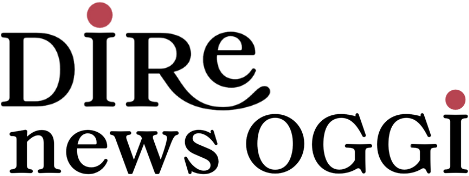La motivazione alla base del presente saggio è la ricerca delle radici cristiane nell’essenza di Europa. Quale congiunzione esiste tra Europa e Vangelo? In prima istanza questa “e” che congiunge le due parole potrebbe esprimere una sostanziale identità. Però tale interpretazione sarebbe impropria poiché il Vangelo, a differenza del Vecchio Testamento, non si identifica con nessuna cultura. Certo bisognerebbe in questa istanza chiarire anche il concetto di cultura. La cultura non è da confondersi con l’erudizione. Essa rappresenta un fattore non biologico, ma etnoantropologico legato alle circostanze del microcosmo in cui l’individuo cresce. Il Vangelo è, dunque, trascendente rispetto alle culture e perciò evangelizzare non va sovrapposto ad europeizzare. Il Vangelo, proprio come il Logos e la sua versione incarnata cioè il Cristo, ha al suo interno un intrinseco dinamismo, cioè l’amore, il quale lo spinge ad incontrare la storia e gli uomini. È, infatti, l’amore l’essenza del cristianesimo ed è esso che muove l’universo, come riportato anche dal celebre verso dantesco «L’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, XXXIII, v. 145). Ipotizzando che il Cristo/Logos fosse solo una mera eternità divina, esso non potrebbe appartenerci, mentre se fosse solo temporalità umana non potrebbe liberarci. Solo concependolo come Dio che si è fatto uomo si potrebbe spiegare tutto il resto. La medesima cosa vale per il Vangelo e l’Europa. Se si parla di radici cristiane dell’Europa non lo si fa per una coincidenza tra Vangelo ed Europa. La Parola di Dio non è solo per l’Europa, ma per tutte le culture1.
La volontà di tenere assieme Vangelo ed Europa appartiene sicuramente al passato della nostra storia, a tal proposito si può ritenere corretto parlare di radici giudaico-cristiane d’Europa. Negli ultimi anni, la Cancel culture sta portando avanti una vera e propria campagna denigratoria contro tale tema, identificandolo come “mito”. Le radici cristiane d’Europa sono però un fatto storico e non interpretativo. Parlare di radici comporta sempre un volgersi al passato, un guardarsi indietro. Da più di sessant’anni l’Europa comunitaria è un cantiere aperto, caratterizzato da un continuo divenire. Settanta tre anni sono trascorsi da quando, nel 1951, i sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) con il trattato di Parigi istituirono la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Molto si è camminato da quando, nel 1957, i trattati di Roma diedero vita alla Comunità Economica Europea (CEE) e alla Comunità Europea per l’Energia Atomica (EURATOM). Sono, invece, più vicini a noi, l’Atto Unico Europeo (1986), il trattato di Maastricht sull’Unione Europea (1992) e il trattato di Amsterdam (1997) hanno contribuito a creare tra gli Stati membri (che nel frattempo sono divenuti quindici) vincoli così saldi da rendere possibile un traguardo che a molti sembrava irrealizzabile: l’unione monetaria (1999) e l’adozione dell’euro come moneta unica (2002). Durante tutto questo cammino costantemente ci si è chiesti cosa tenesse realmente assieme l’Europa, quale fosse il tratto comune. Non si può negare che l’Unione Europea sia nata e si sia sviluppata soprattutto come comunità economica. Ma l’Europa non può essere tenuta assieme dalla sola e pura economia comunitaria, deve esserci qualcosa di più profondo. Si possono unificare tanti stati solo sulla base economica. Si interrogava su tale quesito Jean Monnet, che dell’unità economica fu il principale architetto. Pochi giorni prima di morire, confessava: «Se l’Europa fosse da rifare, comincerei dalla cultura»; infatti, commenta lo storico F. P. Braudel, «noi non coalizziamo gli Stati, noi uniamo gli uomini»2. Non si possono unire stati e popoli solo sulla base economica, ma bisogna partire dalla cultura. È necessario costruire insieme un grande soggetto politico, che abbia forza e autorità di prendere democraticamente decisioni vincolanti per tutti, nel rispetto della identità degli Stati membri. Senza tanti giri di parole, fatta eccezione dai paesi linguisticamente neolatini, dunque, con un carattere in più in comune, tutti gli altri hanno in comune le radici religiose cristiane, siano esse cattoliche, ortodosse o protestanti. Il dibattito sulle radici comuni d’Europa si è acceso sempre più dagli anni 2000 a questa parte. A tal proposito ricordiamo come dall’avvento dell’Islam e dalla sua espansione lungo il sud del Mediterraneo è sorta una contrapposizione tra cristiani e mussulmani. Ricordiamo come Henri Pirenne, uno dei maggiori medievisti d’Europa assieme Le Goff, nel suo Maometto e Carlo Magno affermi che l’Impero Romano d’Occidente e la classicità tutta non finiscano con la caduta del primo, ma con l’arrivo dei mussulmani nel Mediterraneo3. Nel mantenimento di una classicità europea post avvento dell’Islam, la figura dell’imperatore è stata sostituita gradualmente da quella del Pontefice4. Insomma, l’unità territoriale dell’impero romano è stata sostituita da quella religiosa/spirituale del cristianesimo.
Tornando al dibattitto corrente su tali radici, in data 6 febbraio 2003 a Bruxelles il presidente della «Convenzione», V. Giscard d’Estaing, ha presentato all’assemblea plenaria la bozza dei primi 16 articoli della Costituzione comunitaria, i quali definiscono la natura dell’Unione, i suoi obiettivi e le sue competenze, nonché i diritti fondamentali dei cittadini europei. Nei suddetti punti non vi è alcun riferimento alle radici cristiane dell’Unione. Ciò riaccese nuovamente il dibattito, anzi lo infervorì. Tale bozza di Costituzione parlando dell’ispirazione ideale dell’Unione, si limita a dire: «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo, valori che sono comuni agli Stati membri. Essa mira a essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia, la solidarietà» (art. 2). La cosa ha portato immediatamente alla delineazione di due schieramenti:
- da una parte, coloro che — condividendo l’impostazione della bozza — vorrebbero fondare l’Unione sui «valori laici» in essa enunciati, senza alcun riferimento alla religione;
- dall’altra, si sono arroccati coloro che insistono sulla necessità di definire l’Unione anche in base alla sua identità storica e culturale, quindi introducendo un richiamo esplicito alle sue «radici cristiane».
Interessante a tal proposito è esaminare l’articolo 2 della Costituzione, il quale propone come valori fondamentali dell’identità europea: la dignità umana, la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell’uomo. Anche se questi oggi sono considerati «valori laici», tuttavia non si può negare la loro originaria ispirazione cristiana. Interessante risulta anche un intervento del 1982 di Giovanni Paolo II: «Dopo venti secoli di storia, nonostante i sanguinosi conflitti che hanno contrapposto tra loro i popoli di Europa e nonostante le crisi spirituali che hanno segnato la vita del Continente — fino a porre alla coscienza del nostro tempo gravi interrogativi sulle sorti del suo futuro —, si deve ancora affermare che l’identità europea è incomprensibile senza il cristianesimo, e che proprio in esso si ritrovano quelle radici comuni dalle quali è maturata la sua intraprendenza, la sua capacità di espansione costruttiva anche negli altri continenti; in una parola, tutto ciò che costituisce la sua gloria»5.
Guardarsi indietro vuol dire però volgere lo sguardo alla propria storia e quella europea non può essere scissa da quella cristiana. Il cristianesimo è stato fonte inesauribile d’ispirazione per la popolazione, o meglio, popolazioni europee. È impensabile un’Europa senza fondamenti cristiani, vorrebbe dire negare la storia stessa. Basta gettare uno sguardo al patrimonio culturale europeo e rievocare tutte le grandi creazioni dell’arte: dalla letteratura alla musica, dalla pittura alla scultura. Cosa sarebbe l’Europa senza cristianesimo, cosa le rimarrebbe? Come potremmo dibattere sulla cultura slava senza riferimenti a Cirillo e Metodio? Potremmo ancora parlare di cultura classica senza gli amanuensi che ne hanno salvato i codici?
Per allontanarsi da tali evidenze spesso ci si richiama alla laicità, ma cos’è realmente? In prima approssimazione si può dire che essa consiste nel rifiuto di legittimare un sistema politico attraverso l’autorità religiosa e nella negazione della forza coercitiva da parte di quest’ultima. Questa è una definizione che potremmo definire manualistica, ma che immediatamente ci mette in evidenza un fatto storico, i primi ad opporsi ad un sistema coercitivo religioso furono proprio i cristiani. A tal proposito risultano interessanti le parole di Ferrari: «La laicità è in larga misura un’acquisizione dovuta al cristianesimo, che ha introdotto nella storia – con ben maggiore nettezza dell’ebraismo e soprattutto dell’islam – la distinzione tra religione e politica. Il fatto che la laicità si sia imposta in Europa al di fuori delle Chiese e nonostante la loro opposizione, non toglie che affondi le sue radici nella distinzione tra religione e politica propria del cristianesimo»6. La distinzione evangelica tra Dio e Cesare si oppone ad ogni forma di sacralizzazione della politica e di politicizzazione della religione. Nessun politico può legiferare dicendo “Dio lo vuole”. Dunque, anche la laicità è figlia del cristianesimo e risulta inappropriato opporla ad esso, in quanto le radici in questione non sono più solo religiose, ma costituiscono un amalgama culturale.
1 Si veda la Declaratio finale del Sinodo speciale per l’Europa del 1991.
2 M. A. Macciocchi, Di là dalle porte di bronzo, Milano, Mondatori, 1987, p. 206.
3 H. Pirenne, Maometto e Carlo Magno, prefazione di Ovidio Capitani, Roma-Bari, Laterza, 1976.
4 J. Le Goff, La civiltà dell’occidente medievale, a cura di F. Cardini, Milano, Mondadori, 2021, p. 21; G. Duby, Le società medievali, Torino, Einaudi, 1985, pp. 7-8.
5 Atto europeistico a Santiago de Compostela, in L’Osservatore Romano, 11 novembre 1982.
6 S. Ferrari, Radici cristiane della laicità, in Il Regno -attualità, XLVIII, n. 16, 2003, p. 529.