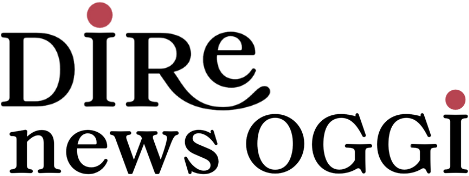L’inchiostro si miscela con il sangue e nel cappio del carnefice finisce colei che era stata il crogiolo nell’arte della comunicazione. Si avviò al patibolo tra la folla dei Lazzari inferociti che intonavano canti di scherno, cui si unirono anche le donne: “A signora donna Lionora /Che cantava ‘ncoppo o triato/Mo abballa mmiezzo o Mercato./Viva viva il papa santo/Ch’ha mannato i cannuncini,/pe scaccia li giacubini/.Viva a forca e Mastro Donato,/Sant’Antonio sia priato”. Il 20 agosto 1799 nella piazza del Mercato di Napoli, la forca pose fine alla vita di Eleonora De Fonseca Pimentel. Alle due pomeridiane con un concorso di popolo senza precedenti cadde vittima della reazione borbonica l’eroina della breve e sfortunata repubblica partenopea. Il fallimento era da addebitarsi al distacco dei patrioti dalle masse contadine e cittadine e ai Giacobini che avevano imposto leggi e programmi generati in una terra diversa dal contesto storico italiano, soprattutto napoletano. Quella rivoluzione aveva prodotto un primo germe di unità italiana. Eleonora ne fu l’anima. Nata il 13 gennaio 1752 a Roma da Don Clemente Henriquez di origine portoghese e da Caterina Lopez spagnola, abitò in via Ripetta 22. Un palazzo borghese con un portale scuro dove campeggiava in alto uno stemma nobiliare ovale: un leone rampante e ai battenti due teste leonine. Sulla facciata della casa ancora oggi si legge la lapide che il Comune di Roma le dedicò a ricordo il 20 agosto 1899: In questa casa nacque il 13 gennaio 1752 Eleonora De Fonseca Pimentel scienziata e poetessa morta in Napoli al 20 di agosto 1799 martire della libertà. A Roma compì i primi studi e scrisse i suoi primi versi. Giunse a Napoli a nove anni. La città chiassosa e vitale le infondeva allegria. La marea di panni stesi alle finestre e il puzzo delle strade, la vera Napoli. Delusa e piangente giurò da quel momento di aiutare il popolo napoletano. Sul trono di Napoli regnava l’ancora fanciullo re Ferdinando sotto la guida di otto reggenti. Semianalfabeta e rozzo, Ferdinando aveva di fronte a sé uno scenario terrificante. Nella città affluivano i lazarielli, banditi e fannulloni, chiamati lazzaroni la cui unica ricchezza era rappresentata dalla camicia e i pantaloni che indossavano. Di questa gente ce n’era parecchia e sia Eleonora che i Giacobini volevano servirsene per rovesciare i Borboni e instaurare una repubblica dove trionfassero la libertà e l’uguaglianza. I Lazzari non si “affezionavano” ad alcun potere, pronti a difendere solo chi gli dava da mangiare. Affascinata dal settecento riformatore, dopo essere stata poetessa di corte e bibliotecaria della regina Carolina, la colta e geniale Eleonora prese a cuore la questione sociale. Scrisse un progetto di banca nazionale e un saggio di diritto pubblico dove espresse la necessità che il Regno di Napoli si svincolasse dall’ingerenza della Chiesa per diventare un Regno di amministrazione e di difesa dei diritti pubblici della nazione ed anche dei diritti privati di ciascun cittadino. Delusa dal re Ferdinando incapace di comprendere la necessità delle riforme nel suo regno, da ardente monarchica diventò sfrenata giacobina. Si collegò con i Giacobini napoletani, tenne contatti con i compatrioti del suo paese d’origine e per questo sospettata e poi arrestata. La monarchia cadde poco dopo e il re Ferdinando si rifugiò in Sicilia. Lei riconquistò la libertà. Appena uscita dal carcere occupò insieme ad altri patrioti il Castello di Sant’Elmo da cui furono cacciati i Lazzaroni e i villani che se ne erano impadroniti. Da lì si gridò viva la repubblica, fu piantato l’albero della libertà, dichiarata decaduta la monarchia e proclamata la Repubblica Napoletana una e indivisibile sotto la protezione della nazione francese. Dopo questa esperienza diresse il Monitore, il giornale che usciva due volte la settimana con articoli e osservazioni scritti totalmente da lei. Dava voce al patriottismo, discuteva dei rapporti con la Repubblica francese, della politica da adottare per la plebe, che diffidava dei patrioti perché “non li intende” e così nel secondo numero scrisse un’arringa al popolo in dialetto. Tutto è possibile a Napoli, in tempo di repubblica come di monarchia purché ci sia il benestare di San Gennaro e questa volta l’umore liquefatto dentro l’ampolla dimostrò che anche lui s’era fatto giacobino. Attraverso le pagine del Monitore Eleonora riservò ai sovrani fuggitivi acerbe invettive. I primi scricchiolii della Repubblica si avvertirono quando il corpo francese si ritirò da Napoli. Eleonora scriverà che un popolo non si difende mai bene che da sé stesso e che l’Italia indipendente e libera è utile alleata. Il Ruffo era già alle porte di Napoli e il Monitore cessò la pubblicazione. Cinquecento patrioti partirono esuli per la Francia, lei imprigionata alla Vicaria, il 17 agosto fu condannata a morte. Ebbe un contegno fermo fino all’ultimo. Donna Eleonora aveva mostrato coraggio anche nella vita privata. Incontrato a un ballo il tenente Tria de Solis di 44 anni, lei ne aveva 25, si accorse presto che non era un uomo colto ma ci sapeva fare con le donne. Nozze assurde tra la musa della poesia e il rozzo tenente. Durarono poco. Eleonora è tradita, battuta, cerca di tener testa all’amante popolana del marito piazzata in casa sua con la figlia. Si parla di un menage a tre, di debiti, di botte. Rimane incinta per la seconda volta ma abortirà a causa dei maltrattamenti. Villanie perpetrate dal marito per impedirle di frequentare gli intellettuali che non comprendeva al pari del popolo rozzo. Diventava furioso se la sorprendeva a leggere e a scrivere. Il capitano trovava la felicità solo con la sua rozza amante, la Cuffara, che faceva dormire nel letto insieme alla moglie. In un eccesso di collera le rinfacciò le relazioni con i suoi amici di cultura e le sbatté in faccia le lettere da lui intercettate, mai lette da Eleonora. Al processo di separazione lei confermò tutti i patimenti subiti mentre lui a sorpresa dichiarò che la moglie era una donna onestissima. Pieno di debiti aveva accettato il denaro offertogli dal suocero per chiudere la questione. Dalla finestra della Vicaria Eleonora vedeva fiammeggiare il Vesuvio entrato in eruzione. Le ultime notti le aveva passate ripensando a tutta la sua vita, in testa i versi di Virgilio: Forsan et haec olim meminisse juvabit (E forse un giorno gioverà ricordare tutto questo). Chiese che le venisse fornito un laccio per chiudere i lembi del suo abito nero, sapeva che la forca era stata issata in alto circa una decina di metri e lei avrebbe penzolato priva degli indumenti intimi. La compiacenza oscena del popolo era diretta alla giacobina e alla donna che aveva osato sfidare l’uomo nel suo incontrastato dominio intellettuale.

Eleonora De Fonseca Pimentel, eroina della Repubblica napoletana
di