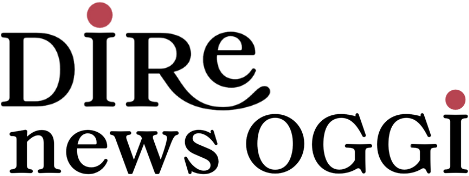Per prima cosa va detto che la chiesa latina ha taciuto sulle chiese locali per tutto il secondo millennio. A tal proposito va detto che durante la Commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, papa Francesco ha sostenuto che «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla chiesa del terzo millennio». Il Pontefice ha poi aggiunto: «Una chiesa sinodale è una chiesa dell’ascolto […]. È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare […]. È ascolto di Dio, fino ad ascoltare con lui il grido del popolo; ed è ascolto del popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama»2. Una svolta per quanto concerne il discorso teologico sulla chiesa locale si ebbe con il Concilio Vaticano II3. La terminologia utilizzata durante il Concilio Vaticano II per indicare il rapporto ambivalente tra chiesa universale e chiesa locale è molto eterogenea e tiene conto dei vari contesti. Nei documenti prodotti dal Concilio il termine “chiesa” è menzionato 45 volte accompagnato dall’aggettivo greco “cattolica”, 25 dall’aggettivo “universale” e 23 come “intera”. In tutti i testi prodotti dal Concilio il termine “chiesa locale” è utilizzato solo 8 volte, delle quali in 4 ci si riferisce alle singole diocesi, in due ad un raggruppamento di diocesi, in una al contesto socio-culturale e in un solo caso relativo alla singola parrocchia. Spesso, in sostituzione del termine “chiesa locale” si utilizza volutamente “chiesa particolare”4. Tale termine nella documentazione è utilizzato ben 24 volte, delle quali in 12 viene disegnata la diocesi e nelle restanti la chiesa nel suo contesto particolare socio-culturale5. I redattori conciliari sembrano privilegiare tale terminologia ripresa poi dal Codice di diritto canonico del 1983. Va però detto che numerosi teologi prediligono il termine “chiesa locale” o “diocesi”, poiché tale formula risulta più vetusta rispetto a quella conciliare. Il termine risulta, inoltre, più legato alla tradizione cattolica e certamente più esplicativo. Nella documentazione conciliare è però possibile riscontrare delle istanze di fondo anche queste poi riprese nei canoni 368-374 del Codice di diritto canonico del 1983. Già nel decreto sui vescovi i documenti conciliari discernono tra l’esercizio del ministero a livello universale e a livello locale. Va però riconosciuta al Concilio un’apertura verso la chiesa locale che negli anni successivi ha permesso enormi passi in aventi relativi alle minime autonomie particolari. Tornando alle parole del Pontefice, esse aprono su un punto fondamentale. Ogni chiesa locale è chiamata a sviluppare «una disciplina propria, dei riti liturgici e un patrimonio teologico e spirituale propri» (LG 23)6. In altre parole, si può affermare che ora la sinodalità costituisca il «modo più adeguato per la genesi dei processi d’identità e riconfigurazione teologico-culturale della chiesa, secondo le epoche e le culture, all’interno di un modello di chiesa come chiesa di chiese, presieduta dal Vescovo della chiesa di Roma e in comunione con tutte le chiese»7. Il concilio Vaticano II ebbe il fondamentale ruolo di recupero del significato della chiesa locale e della sua relazione intrinseca con la Chiesa universale. La Lumen gentium individua come fondante «nelle [chiese locali] e a partire da esse esiste la chiesa cattolica una e unica e questa varietà di chiese locali tendenti all’unità, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della chiesa indivisa»8. Inoltre, sempre dal Concilio ai vescovi è riconosciuto sia il ruolo di pastori del singolo gregge, che quello di rappresentati nel contesto particolare di tutta la Chiesa universale. «La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali di un vescovo coadiuvato dal presbitero, in modo che, aderendo al suo pastore, e da lui, per mezzo del Vangelo e dell’eucaristia, riunita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo». Il Concilio volle dare tanto spazio alle diocesi proprio per ricucire la frattura latente che nella Chiesa si era creata tra Chiesa centrale di Roma e diocesi.
1 Istruttore direttivo Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo.
2 Francesco, Discorso nel 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi (17 ottobre 2015), in https://tinyurl.com/2p97zfn8 (24.1.2022).
3 G. Canobbio, Il vescovo tra Chiesa universale e Chiesa locale, in Firmana, 2005, n. 38/39, pp. 153-172.
4 D. Vitali, Chiesa universale e Chiesa locale: un’armonia raggiunta?, in M. Vergottini, La Chiesa e il Vaticano II. Problemi di ermeneutica e recezione conciliare, Milano, Glossa, 2005, pp. 241-242.
5 S. Pié-Ninot, Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana, in Queriniana, 2008, p. 354.
6 Francesco, Discorso nel 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi (17 ottobre 2015), in https://tinyurl.com/2p97zfn8 (24.1.2022).
7 R. Luciani, La sinodalità come processo di riconfigurazione teologico-culturale delle chiese locali, in CredereOggi, n. 247, 2022, pp. 113-132.
8 R. Luciani – S. Noceti, Colegialidad, sinodalidad y eclesialidad. Un camino para profundizar en la recepción del Vativano II, in Vida Nueva, 3220 (Pliego 24-30 aprile 2021), 24-30.