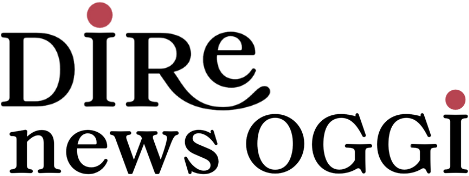Considerando i criteri dell’attuazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere “deve essere garantito alle donne un percorso completo, dall’accoglienza all’autonomia, tenendo conto delle sue esigenze specifiche”.
Uno studio dell’organizzazione WAVE (Women Against Violence Europe) ha mostrato come nel nostro Paese manchi l’87% del numero di strutture previste ad accoglierete vittime di violenza. A novembre 2020 solo il 10% dei finanziamenti per azioni/servizi in contrasto alla violenza contro le donne stanziati nel 2019 è effettivamente arrivato ai centri antiviolenza. Un piccolo passo avanti è stato fatto a gennaio 2021, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la ripartizione alle Regioni dei fondi del Piano Nazionale Antiviolenza 2020. Da quel momento è compito delle amministrazioni locali predisporre i piani di utilizzo dei fondi per ripartirli.
Permane una distanza tra le norme adottate e declamate e la loro concreta, omogenea applicazione nel territorio nazionale, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza.
Il costo della mancanza di azioni di contenimento di tale emergenza è significativo tanto per le sopravvissute, quanto per le loro famiglie e la società in generale.
Per raggiungere l’indipendenza da un partner violento sono utili un buon livello d’istruzione e un lavoro, ma non sempre bastano di fronte ai diktat che limitano risorse e sfera di azione. Lo rileva il rapporto “Una via d’uscita dalla violenza”, che ActionAid ha lanciato nel 2022, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e presentato il 30 novembre al Parlamento Europeo a Bruxelles. Il rapporto evidenzia come l’indipendenza economica sia un fattore decisivo, e ciò a fronte del fatto che in vari casi le donne maltrattate, pur lavorando, non sono libere di utilizzare i propri soldi liberamente; spesso le spese sono controllate dal partner o non sono a conoscenza nemmeno dell’entità del reddito familiare.
Il progetto “WE GO!” cofinanziato dalla Ue fornisce raccomandazioni alle istituzioni per le politiche di “empowerment” economico delle donne vittime di violenza. Lo studio sul profilo economico di chi si rivolge ai Centri antiviolenza ha coinvolto 552 persone in 4 Paesi europei: Bulgaria (1 Centro antiviolenza), Grecia (6), Italia (3) e Spagna (2). L’82,5% delle donne che si sono rivolte ai Centri risulta avere un basso livello di indipendenza economica: solo il 17,5% è indipendente, nonostante il 40,9% lavori; il 59,1% non ha lavoro. Il 73,7% ha figli a carico e solo il 13,3% vive in una casa propria, contro il 14,8% che ne condivide la proprietà con il marito/partner. Il 53% delle donne ha subito forme di violenza economica: il 22,6% dichiara di non avere accesso al reddito familiare, il 19,1% non può usare i suoi soldi liberamente e per il 17,6% le spese sono controllate dal partner; il 16,9% non conosce il reddito familiare, il 10,8% non può lavorare. Il 32,5% ha 30-39 anni, il 29,2% ha 40-49 anni, il 21,8% ha 18-29 anni, il 16,5% è ‘over50’.
La maggioranza ha una buona istruzione: il 38,8% un diploma di scuola superiore, il 22,7% ha studi universitari. Il 29,6% si ferma alla primaria o secondaria di primo grado, solo il 9% ha un livello d’istruzione inferiore alla scuola primaria. Il periodo della violenza è lungo: il 23,7% ha subito dai 5 ai 10 anni, il 26,5% per oltre 10 anni. Se l’autore è partner o marito, aumentano le donne che subiscono violenza per lunghi periodi di tempo: il 27% la subisce dai 5 ai 10 anni e il 32,7% per oltre 10 anni. Lo studio conferma che l’autore della violenza è spesso marito/compagno (41,7%) o ex-marito/ex-compagno (48,7%).
Un aiuto concreto da parte delle istituzioni dovrebbe volgere sul garantire un lavoro alle donne vittime di violenza e nel riconoscere l’importanza delle case di secondo livello (oltre alle case rifugio) per soluzioni di medio-lungo periodo che diano il tempo per costruire l’indipendenza economica.