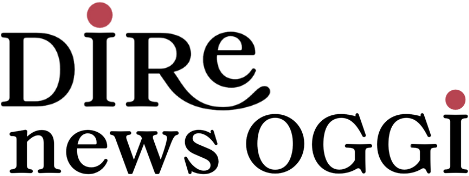L’Alto Potenziale Cognitivo è una caratteristica che coinvolge solo il 2,5% della popolazione. La plusdotazione viene definita per QI (Quozienti Intellettivi) di valore indicativamente intorno ai 130, caratterizzati da discrepanze importanti che vanno considerate in maniera specifica. Tali discrepanze riguardano i risultati ottenuti nei vari indici che, insieme, andranno a identificare il QI totale. I dislivelli sono soventemente così rilevanti da non rendere il QI Tot. interpretabile, ragion per cui, in corso di valutazione, si fa riferimento allo IAG (Indice Abilità Generali).
Con il termine plusdotazione si va a identificare quelle persone in possesso di un potenziale e di un livello eccezionale di abilità o competenza in uno o più domini. Con domini si fa riferimento a ogni area strutturata di attività che utilizza un proprio specifico sistema simbolico (matematica, musica, linguaggio) e un insieme di capacità senso motorie (pittura, danza, sport).
In Italia si parla di Alto Potenziale Cognitivo (o APC) quando il punteggio del Quoziente Intellettivo è uguale o superiore a 120, mentre si parla di Plusdotazione quando il QI risulta uguale o superiore a 130. In letteratura molte sono le definizioni e i modelli teorici proposti rispetto alla Giftedness; tuttavia è bene precisare che non tutti i modelli considerano esclusivamente il QI come unico parametro di identificazione, anche se spesso risulta uno dei criteri maggiormente utilizzati.
La Giftedness è uno sviluppo asincrono in cui abilità cognitive avanzate e un’accresciuta intensità emotiva si combinano per creare esperienze e consapevolezza interiori qualitativamente diverse dalla norma. Questa mancanza di sincronicità aumenta con l’aumentare della capacità intellettuale. L’unicità della Plusdotazione rende questi individui particolarmente vulnerabili e richiede modifiche nella genitorialità, nell’insegnamento e nella consulenza formativa, affinché possano svilupparsi in modo ottimale.
Nei soggetti plusdotati è frequente la comorbilità con altri disturbi (Disturbi dello Spettro Autistico, DSA, ADHD,…) e, in questi casi, si parla di Twice Exceptional. Una persona gifted è caratterizzata da pensiero divergente ed arborescente, in altre parole dobbiamo pensare a delle idee che si sviluppano ad una rapida velocità, creando connessioni su connessioni, aprendo continuamente finestre. La difficoltà spesso risiede nel riuscire a chiudere queste finestre e riuscire a focalizzarsi sull’obiettivo. I soggetti APC sono inoltre caratterizzati da un’estrema sensibilità ed un grande rigore etico e morale, che non gli consentono di tollerare le ingiustizie. È frequente la presenza di una discrepanza tra maturità cognitiva ed affettiva, elemento che può concorrere alla presenza di difficoltà di relazione coi pari.
La precocità nell’acquisizione di abilità e competenze relativamente al linguaggio, elevate abilità di ragionamento astratto, estrema curiosità e ottima memoria rispetto ai pari possono talvolta avere conseguenze sull’adattamento sociale. La discrepanza che presentano tra sviluppo cognitivo e socio-emotivo comporta infatti difficoltà nella gestione e regolazione emotiva, unita a un estremo perfezionismo e a un’attivazione cognitiva intensa, esponendoli al rischio di esclusione o di misdiagnosi.
Immaginiamo la mente che corre veloce, che si distanzia dall’ottica sequenziale che caratterizza per la maggior parte l’ordinamento scolastico, immaginiamo anche una rapidità di pensiero che porta a trovare le soluzioni senza avere coscienza del processamento che vi è dietro, immaginiamo inoltre una delicatezza dell’anima che porta a vivere ogni discriminazione ed ogni violazione fatta ad altri come se fosse rivolta a sé stessi. Se riusciamo ad immaginare questo riusciremo a capire come sia importante aiutare i soggetti APC a divenire resilenti consentendogli di capire che non sono sbagliati, ma che sono semplicemente diversi, come lo è del resto ogni individuo rispetto al prossimo.
Per comprendere l’Alto Potenziale Cognitivo è importante uscire dall’approccio nomotetico, che presuppone che tutte le caratteristiche umane, incluso il potenziale umano o l’attitudine, possano essere viste come normalmente distribuite e quindi soggette a misurazione oggettiva per adottare, invece, un approccio idiografico, centrato sulla persona e che tiene conto della funzionalità dell’intero soggetto rispetto a contesti specifici. Questa prospettiva consente di superare una visione stereotipata della Plusdotazione che presuppone che possedere un APC sia garanzia di successo nel percorso scolastico e di vita o ancora pregiudizi legati alla difficoltà nella gestione emotiva e comportamentale, soprattutto a causa dell’asincronia dello sviluppo che li porta spesso ad essere considerati strani, bizzarri e anche ingestibili.
L’eccezionale abilità dimostrata in un certo campo non necessariamente si estende anche in altre aree: a livello scolastico è frequente che i bambini gifted mostrino interessi e capacità eccellenti in un determinato ambito e che in altre discipline raggiungono invece risultati nella media o addirittura al di sotto. Per questo la Plusdotazione non sempre può essere considerata un punto di forza, ma a volte è accompagnata da fattori di rischio, come lo sviluppo asincrono tra abilità cognitive e abilità socio-emotive, conflitti e isolamento sociale o sentimenti di inadeguatezza e incomprensione a causa del peso delle aspettative.
A volte il desiderio del bambino plusdotato di condividere le sue conoscenze può essere visto dagli altri come un tentativo di ostentazione e può portare al rifiuto da parte dei pari. Le elevate aspettative degli studenti plusdotati su loro stessi e sugli altri possono portare a perfezionismo, insoddisfazione personale o addirittura a sentimenti di disperazione. A causa delle caratteristiche uniche che essi possiedono, gli insegnanti devono essere consapevoli dei modi in cui questi attributi si manifestano nei comportamenti osservabili in classe.
L’elevata intensità emotiva e sensibilità estrema portano talvolta ad avere reazioni apparentemente esagerate, tipiche di bambini con un’età cronologica inferiore e ad adattare comportamenti più reattivi di fronte a stimoli che, in altri bambini della stessa età, non provocherebbero particolari reazioni; ciò li porta a essere facilmente sopraffatti dai propri sentimenti, con una conseguente dis-regolazione emotiva.
I contesti di crescita, come quello familiare o quello scolastico, sembrano avere un ruolo determinante nel permettere al bambino di sviluppare ed esprimere appieno le sue capacità, soprattutto se propongono percorsi di supporto personalizzati in base alle caratteristiche e alle necessità che il singolo bambino manifesta, in modo da accogliere le richieste di approfondimenti e contenuti sfidanti, ma anche di supportare e potenziare le abilità più fragili, come le competenze socio-emotive.
I bambini plusdotati hanno una profonda motivazione intrinseca a padroneggiare il dominio in cui mostrano elevate abilità e possono concentrarsi così intensamente sul lavoro in quel dominio da perdere cognizione del mondo esterno. Quando i bambini plusdotati non sono sufficientemente impegnati a scuola, a volte perdono la loro motivazione e ottengono risultati inferiori alle loro possibilità. Quando i genitori e le scuole cercano di costringere tali bambini a ridurre l’attività propria del dominio della loro plusdotazione rischiano di soffocare la spinta e dunque la loro motivazione. Si formano inoltre aspettative e standard secondo la loro età mentale piuttosto che secondo la loro età cronologica, che possono portare a sentimenti di colpa o di frustrazione quando questi obiettivi non vengono raggiunti.
Il cervello degli studenti plusdotati sembra riflettere interconnessioni più forti rispetto al cervello “medio”, per cui una dotazione di schemi cerebrali più sofisticati si attiverebbe durante compiti cognitivi di livello superiore. I bambini plusdotati smettono di funzionare al loro pieno potenziale una volta acquisita la padronanza nel compito, motivo per cui sono spesso resistenti al lavoro scolastico ripetitivo. I bambini dotati dimostrano una rapida elaborazione delle informazioni che richiede tipicamente molta meno ripetizione per l’apprendimento, anche se a volte, paradossalmente, appaiono più lenti per le risposte a domande di basso livello, presumibilmente perché tendono ad interpretare la domanda ad un livello di maggiore sofisticazione rispetto a quanto ci si aspetterebbe.