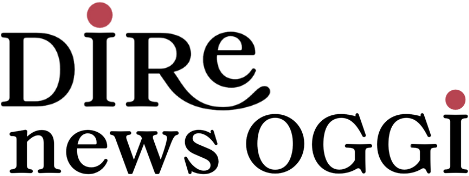Tutta l’opera di Petrarca si caratterizza per invettive contro papi e cardinali durante la cattività avignonese. Petrarca si sentiva profondamente ferito nel suo animo di cristiano a vedere il lusso e lo sfarzo delle corti papali e cardinalizie. Il rapporto tra Petrarca e le corti in generale fu molto intenso, poiché passò la maggior parte della sua vita al loro interno. L’esperienza cortigiana petrarchesca ebbe inizio a partire dal suo apprendistato presso la corte cardinalizia dei Colonna, ove il giovane poeta ebbe modo di ampliare progressivamente le sue competenze curiali e politiche, partecipando ad importanti missioni diplomatiche. Anche in questa esperienza Petrarca non poté fare a meno di notare l’enorme sfarzo della corte del Colonna. L’esperienza cortigiana del Petrarca non fu però solo religiosa, ma anche laica. Ad esempio le signorie dell’Italia settentrionale mostrarono di considerare Petrarca, ben introdotto in Curia ed apprezzato da una schiera di giuristi, una figura capace di conferire prestigio a chi se ne facesse ospite e protettore. La produzione petrarchesca, oltre che di invettive, risulta ricca anche di componimenti poetici di carattere encomiastico, che si affiancano a un numero considerevole di passi e lettere dedicati a una frammentaria ma significativa trattazione de principe. Inoltre, dedicatari di alcune delle sue opere più importanti sono i signori. Tali opere mettono in campo una tematizzazione del rapporto tra poeta e mecenate di stampo classico destinata ad un’ampia fortuna nei due secoli seguenti. Tale rapporto però così celebrato da Petrarca lo si riscontra solo durante i soggiorni in corti laiche, mentre per quelle cardinalizie egli trova sempre a ridire. Il problema della cattività avignonese toccò nel profondo Petrarca, anche dal punto di vista della fede. In numerose udienze chiese ai papi di ritornare presso la sede romana e frequentemente polemizzò contro la sede avignonese in passi del Secretum, delle Epistume sine nomine, delle Familiares e nei sonetti anti-avignonesi (136, 137, 138) del Canzoniere. La tematica anti-avignonese in Petrarca è così forte poiché essa è legata al recupero dell’italianità della sua vita e del suo pensiero politico. Roma ai suoi occhi appare come la sede naturale del papato e dell’impero. La crisi romana si era aperta nel 1303 con la morte di Bonifacio VIII e il trasferimento della corte papalina presso Avignone, conseguenza di ciò l’elezione di sette papi francesi (B. Guillemain, I papi di Avignone, 1309-1376, traduzione dal francese di Bruno Pistocchi, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2003, p. 56). Essenziale per comprendere la temperie culturale avignonese dell’epoca è la Descriptio Romandiole del cardinale Anglic Grimoard de Grisac redatta nel 1371. Questa risulta essere una fonte di grande suggestione e di altrettanto grande valore storico ormai sufficientemente studiata nei suoi molteplici aspetti strutturali ma ancora in gran parte sconosciuta per quel che riguarda la figura dell’estensore e, più latamente, il retroterra socioculturale dell’ambiente avignonese che l’espresse.
Tornando a Petrarca, se egli era solo un ragazzino al tempo della calata in Italia di Enrico VII di Lussemburgo, una volta cresciuto ha seguito con interesse i tentativi di Luigi IV al fine di restaurare l’autorità imperiale in Italia. Tentativi ai quali papa Giovanni XXII si oppose con estrema fermezza. Sotto Innocenzo VI, Egidio d’Albornoz cercò di restaurare l’autorità papale nella penisola, condizione, questa, indispensabile per il ritorno della sede papalina a Roma. Cola di Rienzo, personaggio amato profondamente da Petrarca, morì nel 1354. Negli stessi anni Santa Brigida di Svezia e Santa Caterina da Siena operarono per il ritorno dei papi a Roma. La polemica anti-avignonese origina in Petrarca proprio dalle tante, troppe, delusioni politiche. Né si possono minimizzare le amarezze provate nel vedere gli sfarzi della corte avignonese. Le sue invettive anti-avignonesi sono però del tutto particolari e si differenziano da quelle dantesche che invece evidenziano solo un’ostilità nei confronti dei pontefici divenuti vassalli del re di Francia, tralasciando l’accusa nei confronti di Filippo il Bello che aveva osato fare violenza alla Chiesa tutta umiliando Bonifacio VIII, Dante riproverà alla Chiesa avignonese il suo attaccamento al denaro e la sua schiavitù nei confronti dei monarchi francesi. Le accuse avanzate da Dante sono le medesime degli spirituali francescani, ai quali il Sommo Poeta fu sempre molto vicino. Le accuse petrarchesche sono invece molto più viscerali, Petrarca sente il papato avignonese come contro natura. Facendo un paragone forzato, ciò che per dante fu la cacciata da Firenze, per Petrarca fu la cattività avignonese, una sede contronatura che svuotava Roma della sua solennità.
Bibliografia
R. De Mattei, Il sentimento politico del Petrarca, Firenze, 1944;
H. Baron, The Evolution of Petrarch’s Thought in Id., From Petrarch to Leonardo Bruni, Chicago-London, 1968, pp. 7-50;
F. Gaeta, Dal comune alla corte rinascimentale,in Letteratura italiana, vol. I, Torino, 1982, pp. 149-255;
M. Feo, L’epistola come mezzo di propaganda politica in Francesco Petrarca, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Roma, 1994, pp. 218-221;
M. Simonetta, Rinascimento segreto: il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli, Milano, 2004.
B. Guillemain, I papi di Avignone, 1309-1376, traduzione dal francese di Bruno Pistocchi, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2003, p. 56.